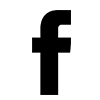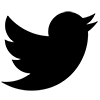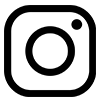Intervento all'Inaugurazione dell'Anno Accademico dell'Università di Teramo
Il tema del controverso rapporto tra economia e diritto, che non può essere ridotto a strumento delle dinamiche economiche ma è destinato a condizionarle, orientarle e riplasmarle. La necessità di rimettere al centro il diritto nella regolazione delle dinamiche economiche globali e nella redistribuzione delle risorse e dei beni. Questi e altri i temi al centro dell’intervento del Vice Presidente del CSM, Giovanni Legnini, in occasione del conferimento dell’Ordine al Merito dell’Ateneo di Teramo.
 Teramo, 28 febbraio 2015
Teramo, 28 febbraio 2015
Quando nel 1984 decisi di concludere i miei studi in giurisprudenza con una tesi in economia politica (sulla politica dei redditi per la precisione) era diffusa l’opinione della prevalenza dell’economia sul diritto. Il resto della mia decisione fu influenzata dalla passione politica giovanile e dalla coincidenza con un intervento legislativo, quello sul taglio della 'scala mobile', destinato a cambiare non solo l'indicizzazione automatica dei salari e ad arginare la forte spirale inflazionistica dell'epoca, ma anche i rapporti tra il potere esecutivo e legislativo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, con implicazioni che immediatamente si manifestarono sul quadro politico generale.
Dedicai quasi un anno alla ricerca degli orientamenti sulla politica dei redditi in Italia, consultando gli atti parlamentari e dedicandomi alla lettura sul punto degli economisti classici, keynesiani e neokeynesiani.
Man mano che le mie conoscenze si estendevano, non mi rassegnavo all’idea, su un tema di tale rilevanza, di un conflitto così dilaniante tra la sinistra sindacale e la politica italiana, da un lato, e le altre forze sindacali e il Governo, che pure aveva agito con un po’ di arroganza a mezzo della decretazione d'urgenza, dall'altro, così da aprire una ferita nel rapporto tra l'autonomia negoziale delle parti sociali e l'ambito di intervento del legislatore.
Il cuore mi diceva di stare dalla parte del sindacato maggioritario, confortato anche dall'opinione di eminenti economisti come Federico Caffè, la ragione mi spingeva verso la direzione opposta, perché era evidente che i salari non venivano tutelati da quel sistema di adeguamento retributivo automatico che veniva divorato da un'inflazione che all'epoca galoppava a tassi superiori al 10%.
Conclusi il mio lavoro, con il sostegno della bravissima ed amabile professoressa Carla Esposito, che voglio ringraziare ancora una volta anche per la sua presenza qui oggi, con l’ulteriore consapevolezza del carattere immanente del conflitto tra la scienza economica e la funzione regolatoria del diritto.
Questa consapevolezza condizionò non poco la mia successiva esperienza professionale ed istituzionale, spingendomi da avvocato, prima, e da parlamentare e membro del Governo, dopo, ad occuparmi della vita delle imprese e della pubblica amministrazione, della politica economica e di bilancio pubblico, della definizione legislativa di istituti giuridici e processuali e profili attuativi incidenti sui processi economici.
A distanza di oltre 30 anni, affidatami dal Parlamento e dal Consiglio la cura di una funzione cruciale qual è quella della giurisdizione, provo a verificare se quella supremazia dell'economia sul diritto può ancora essere sostenuta e riscontrata nella realtà e se lo spazio per l'intervento regolatorio dello Stato nell'economia, quindi lo spazio del diritto, si è ridotto oppure si è accresciuto in conseguenza delle profonde trasformazioni economiche, tecnologiche e sociali degli ultimi decenni, nonché per effetto dell'aggravamento delle ingiustizie sociali a seguito della grande crisi.
L'obiettivo trascende i miei modesti mezzi ed è per questo che richiamerò il pensiero e le tesi di fondo di alcuni economisti, giuristi e intellettuali che da varie angolazioni e in diversi periodi storici si sono occupati dell’inscindibile legame tra economia e giustizia, provando ad accennare ad una conclusione proiettata nel contesto storico che stiamo attraversando.
Il controverso rapporto tra economia e diritto.
Il tema del rapporto tra la regolazione giuridica dei fenomeni sociali e l'utilizzo e la distribuzione dei beni può dirsi un archetipo di ogni modello di società e delle stesse forme di Stato. Lo troviamo già delineato in Aristotele che, ne “La Politica”, precisa che all’economia “spetta di usare i beni a disposizione” e “raccogliere i mezzi necessari ed utili alla vita ed alla comunità politica e familiare”, mentre il diritto, e cioè la Costituzione e le leggi, sono “le strutture che danno ordine alla polis e stabiliscono il funzionamento dell’autorità sovrana”.
Dalla filosofia greca in poi, e fino alla metà del 1800, la prossimità di Economia e Diritto non viene messa in discussione, pur nella loro evoluzione come discipline autonome.
Una concezione separata, se non conflittuale, di diritto ed economia sorge in tempi relativamente recenti, quando nella seconda metà dell’Ottocento l’economia si fonda come scienza autonoma. basata su due assunti di fondo: il cosiddetto individualismo metodologico che postula che le scelte economiche vengano fatte dagli individui autonomamente; e l’assunzione che tali scelte individuali sono guidate dall’interesse, dalla razionalità e dalle informazioni disponibili.
Si rompe così quell’alleanza che vedeva diritto ed economia basarsi su un'idea di società di tipo comunitario, caratterizzata da cooperazione e solidarietà, e il diritto viene visto ora come un utile strumento, ora addirittura come un ostacolo allo sviluppo di un’economia “libera”.
I risultati scientifici conseguiti dalla teorie economiche tendono già alla colonizzazione di altre discipline. Sorge così l’analisi economica del diritto, in base alla quale le norme sono le risposte istituzionali a disfunzioni ed incompletezze dei mercati.
Questo paradigma, come vedremo fra breve, entra in crisi davanti all’incapacità delle teorie economiche di spiegare la complessità e le caratteristiche dei fenomeni moderni, che impongono un ripensamento delle stesse assunzioni di fondo della teoria economica e rimettono al centro il ruolo del diritto nella regolazione delle dinamiche economiche globali e nella redistribuzione delle risorse.
Il breve excursus sul tema non può che prendere il via dal padre dell'economia politica e capostipite della scuola classica, Adam Smith.
L'economista e filosofo scozzese, nel celebre “La ricchezza delle Nazioni”, assume come principio assoluto il sistema di libertà naturale all'interno del quale "ciascun individuo, finché non viola le leggi della giustizia, è lasciato perfettamente libero di perseguire il proprio interesse nel modo che vuole”. La protezione della proprietà privata è la prima esigenza di qualunque forma di governo. "Dove non esiste proprietà ... Un governo civile non è così necessario, ma un sistema giudiziario efficace è essenziale, è il pilastro principale che tiene tutto il palazzo. Se rimosso, la grande e immensa struttura della società umana crollerà in un attimo...". Dunque, per Smith è il mercato che determina tutti i giochi nei rapporti economici, residuando in capo alla giustizia un ruolo sì essenziale, ma strumentale alla protezione della proprietà privata e alle leggi naturali del mercato anzi, come lui diceva, per “difendere i ricchi dai poveri, e quelli che hanno una qualche proprietà da quelli che non ne hanno nessuna”.
Da qui prende le mosse il lungo filone di pensiero liberista che passa per i sostenitori puri del capitalismo e delle sue capacità di autopreservazione e consolidamento. La tesi, volutamente semplificata e acutamente posta in discussione da Michael Walzer, nel suo celebre saggio: “Sfere di giustizia” è la seguente: “Gli esiti del mercato contano moltissimo perché il mercato, se è libero, dà ad ognuno esattamente quello che merita”. L’unico diritto di cui si sente il bisogno è quello che amplia e facilita lo sviluppo di queste forze, così premiando il merito e raggiungendo crescita e sviluppo.
Si tratta del filone di pensiero in voga fino ai giorni nostri declinato in vari modi riconducibili alla nota espressione “laissez faire”.
Per Marx, come è noto agli antipodi della scuola classica, il diritto è una delle sovrastrutture di quei rapporti materiali dell'esistenza e come ogni sovrastruttura può essere compresa solo attraverso lo studio dell'economia politica poiché esso segue l'evoluzione della struttura economica della società.
Il modo di produzione capitalistico spinge per costituire un «mercato mondiale» che garantisca la circolazione delle merci e dei capitali, e sottomette il decisore politico alle esigenze della sfera economica, sicché “il potere statale moderno non è che un comitato che amministra gli affari della classe borghese”.
Sappiamo come si è evoluta la teoria e soprattutto la concreta attuazione della teoria marxiana.
Ciò che qui rileva è la tesi in base alla quale lo studio del diritto si riduce a quello dell’economia, il diritto segue la struttura economica della società.
Da una revisione critica dell'impostazione di Marx prende le mosse anche la tradizione idealista crociana, sensibile al primato della politica. Croce affronta il tema dei rapporti tra economia e diritto da una prospettiva teoretica, includendo il diritto e l’economia nella categoria della filosofia pratica, il cui valore è l’Utilità. “Il fatto giuridico è fatto pratico o di volontà; l'attività giuridica è attività pratica, che non è per sè nè morale nè immorale. Il singolo, per meglio operare utilitariamente, si forma certe massime o leggi e viene a patti con l'altro singolo, e se lo fa schiavo, servo, socio, ecc. perchè gli conviene assai più che distruggerlo. E questa è nient'altro che attività economica”. L'impostazione culturale di Croce tende tuttavia ad affermare la tesi che il diritto ha una sua preminenza specifica e una funzione razionalizzante ed essenziale. Una funzione che nel pensiero italiano del ventesimo secolo, passando persino per l’esperienza fascista prima e per il giuspositivismo poi, tenderà a riaffermare la primazia del diritto come spinta di sviluppo della società.
In opposizione agli estremi a cui giungono la scuola neoclassica da una parte, e il marxismo dall'altra, nasce nel secolo scorso un diverso orientamento, che trova in Keynes la sintesi più efficace.
E’ nota la forza della teoria Keynesiana in punto di opportunità ed effetti dell’intervento pubblico nell’economia. Del pari, è patrimonio culturale comune il forte impatto di tali acquisizioni sulle politiche economiche dei paesi europei e, tra questi, l’Italia. In particolare, giova ricordare l’efficacia della teoria del deficit spending e degli effetti del moltiplicatore sulla domanda e sull’occupazione.
Ciò che qui rileva è che Keynes, come sappiamo, respinge il darwinismo sociale ed economico e assume che una delle implicazioni più rilevanti del legiferare consiste nel determinare ciò che lo Stato dovrebbe prendere su di sé e quanto dovrebbe lasciare, con la minima interferenza possibile, all'attività privata.
“L'intervento più importante dello Stato”, per Keynes, “si riferisce non a quelle attività che gli individui privati esplicano già, ma a quelle funzioni che cadono al di fuori del raggio d'azione degli individui, a quelle decisioni che nessuno compie se non vengono compiute dallo Stato. La cosa importante per il governo non è fare ciò che gli individui fanno già, e farlo un po' meglio o un po' peggio, ma fare ciò che presentemente non si fa del tutto”.
A proposito della tensione tra economisti e giuristi, Federico Caffè arrivò a dire che “l'incontro intellettuale tra giurista ed economista mi sembra realmente difficile”, anche se questo, aggiunge, “non significa che non debba avvenire”. Secondo l'economista abruzzese, “si può continuare a edificare su basi keynesiane, con i necessari adattamenti, anzichè incorrere in affrettati ripudi” e già prefigura problematiche che si imporranno sempre più fino ai nostri giorni:
"Da tempo sono convinto", scrive infatti, "che la sovrastruttura finanziario-borsistica con le caratteristiche che presenta nei paesi capitalisticamente avanzati favorisca non già il vigore competitivo ma un gioco spregiudicato di tipo predatorio, che opera sistematicamente a danno di categorie innumerevoli e sprovvedute di risparmiatori in un quadro istituzionale che di fatto consente e legittima la ricorrente decurtazione o il pratico spossessamento dei loro peculi".
Con gli economisti Keynesiani e neokeynesiani si afferma una diversa lettura del rapporto tra economia e diritto che trova maggiori sponde nel campo della teoria giuridica, a partire dall’affermarsi del principio di eguaglianza, principio cardine delle Costituzioni europee, fino all’art. 3 della nostra Carta Costituzionale, sul quale tornerò in conclusione.
Basti dire, per il momento, della progressiva diffusione della tesi che affida allo Stato e quindi al diritto il compito di soddisfare esigenze di equità, redistribuzione, giustizia sostanziale, così da correggere le anomalie del sistema, il quale non tende affatto alla realizzazione di una meritocrazia effettiva.
Il pensiero di Federico Caffè, che ho sopra richiamato, ci proietta verso l'attualità.
Proviamo a verificare con dati di fatto ricavabili da alcune tra le principali dinamiche economiche di questi anni, se gli spazi della co-estensione del diritto e dell'economia, per dirla con il Prof. Natalino Irti, possono dirsi mutati considerando soprattutto la dimensione globale di quest'ultima e quella prevalentemente nazionale delle regole giuridiche che rimangono chiuse dentro i confini dei singoli stati.
1- La Grande Crisi Finanziaria esplosa negli Stati Uniti tra il 2007 e il 2008, che ha paralizzato il cuore del sistema finanziario mondiale innescando un incendio propagatosi sulle economie reali di gran parte dei paesi sviluppati ed in via di sviluppo, è stata com'è noto causata dalla gestione e circolazione di complicati strumenti finanziari legati alle cartolarizzazioni di crediti bancari di dubbia esigibilità, i cosiddetti mutui subprime, riconducibili ad una più vasta strumentazione di titoli in circolazione annoverabili sotto la categoria della cosiddetta “finanza creativa”. Gli effetti di tale crisi sull'economia mondiale, sull'occupazione, sui redditi e sulla loro distribuzione sono stati devastanti tanto da determinare la più grande recessione dopo quella del 1929.
Quale sia stata la ragione di tale grave crisi lo ha intuito uno degli economisti più autorevoli del mondo, Nouriel Roubini, che nel suo saggio del 2010 'La crisi non è finita' afferma che “decenni di fondamentalismo liberista hanno gettato le basi del tracollo ... è stata spazzata via le regolamentazione bancaria introdotta dopo la Grande depressione e gli operatori di Wall Street hanno trovato il modo di evadere le poche regole rimaste”.
Dunque, non vi è alcun dubbio che il fatto economico di gran lunga più devastante da molto tempo si è generato in virtù della modifica, della mancanza o della violazione di regole giuridiche.
2) La crisi dei debiti pubblici in Europa, che è andata accentuandosi dal 2011, con fortissime ricadute nel nostro Paese, ha comportato decisioni su scala europea e nazionale riconducibili alla categoria dell'austerità, a sua volta fortemente incidente sulle economie nazionali e di gran parte dell'eurozona e quindi sull'occupazione, il reddito e le condizioni sociali di decine di milioni di cittadini Europei.
Il governo di tale difficile passaggio storico, peraltro ancora in divenire, si è giocato per gran parte sul terreno delle regole imposte dalla politica comunitaria e, in primo luogo, dalla Germania. Il Fiscal Compact, il Meccanismo Europeo di Stabilità e le declinazioni nazionali, che nel nostro Paese hanno portato ad introdurre la regola dell’equilibrio di bilancio nell'art. 81 della Costituzione, sono tutte risposte del diritto e degli strumenti propri delle politiche di bilancio, ad una crisi economica e finanziaria che ha determinato ripercussioni gravi sui bilanci pubblici e sulla sostenibilità dei debiti accumulati nei decenni.
Il caso italiano sul punto è emblematico. Ai problemi antichi e recenti della sua economia e della sue politiche di Bilancio, in virtù dei vincoli istituzionali e politici europei, siamo stati costretti o abbiamo voluto dare una risposta sul terreno più avanzato e sensibile dell'ordinamento giuridico, quello costituzionale appunto. L'austerità, con tutte le implicazioni economiche e sociali, assurge al rango di principio costituzionale.
3) Lo strumento dell'imposizione fiscale è all'origine della moderna concezione dello Stato e della Costituzione.
Mi riferisco al noto principio “no taxation without representation” che fu alla base della nascita e dell’evoluzione delle moderne democrazie parlamentari. L’imposizione tributaria riconducibile all’esercizio della sovranità popolare, con il prelievo fiscale che incarna in modo diretto e veemente la potestà di imperio statuale.
La globalizzazione e la dirompente ascesa di internet e delle nuove tecnologie, oltre ad aver cambiato la nostra vita sotto molteplici aspetti, sta producendo fortissime implicazioni economiche e giuridiche, anche in materia di imposizione fiscale.
Quando la ricchezza inizia a sfuggire alle tradizionali maglie ordinamentali, i redditi divengono 'nomadi', come ha scritto la professoressa Silvia Cipollina. E’ allora che l'esercizio della potestà statale per eccellenza entra in crisi, rischia di rompersi o di fortemente attenuarsi quella catena Stato-territorio-ricchezza, fondamentale per qualunque efficace politica economica e fiscale.
La diffusione delle transazioni finanziarie online, le decisioni delle aziende multinazionali digitali di autodeterminare il proprio domicilio fiscale nei paesi con fiscalità vantaggiosa, aggirando il principio della stabile organizzazione aziendale, sono solo i principali fenomeni alla base di comportamenti elusivi verso la potestà impositiva.
Anche qui, per ripristinare il corretto rapporto tra fisco e contribuenti, tra Stato ed entrate fiscali, alla base di qualunque politica redistributiva e di soddisfacimento dei servizi pubblici, ancora una volta è solo su nuove efficaci regole giuridiche che si potrà fare affidamento. E questa volta le norme fiscali andranno determinate in gran parte al livello sovranazionale e per via pattizia tra gli Stati.
4) Da alcuni anni, tra i primi parametri di valutazione dell'attrattività dei sistemi produttivi nazionali, vi è la giustizia e cioè l'esercizio della giurisdizione.
Le regole di risoluzione dei conflitti hanno sempre occupato un posto importante nella valutazione di affidabilità degli Stati ma da qualche tempo esse hanno assunto carattere prioritario. Molti documenti di programmazione economica di provenienza comunitaria contengono un riferimento all'efficacia, tempestività, prevedibilità delle risposte di giustizia degli Stati membri.
Ciò accade in particolare per il nostro Paese dove la funzione dello Stato forse ritenuta più fallimentare è quella giudiziaria, insieme a quella burocratica.
Il rapporto Doing Business del 2014 ci annovera al 147° posto della classifica mondiale sull'efficienza della giustizia civile. Nello 'scoreboard' 2014 sui sistemi di giustizia nella UE del Cepej, l'Italia rimane agli ultimi posti per numero di controversie pendenti (5,5 su 100 abitanti contro una media UE inferiore ai 3 casi per 100 abitanti) e per la durata di risoluzione delle controversie civili si colloca al penultimo posto tra i paese dell'area OCSE.
Secondo diversi osservatori, l'Italia, dopo la Grecia, per tali ragioni, è il Paese europeo meno capace di attrarre investimenti stranieri. Confindustria stima che se il nostro Paese si allineasse alla media europea, potremmo avere un flusso di investimenti in entrata di circa 30-35 miliardi l'anno (circa due punti di Pil) ed alcuni sondaggi indicano che in cima alle preoccupazioni degli investitori stranieri c'è proprio la lentezza dei processi e l'eccessiva burocrazia.
Dunque le sorti dell'economia dei Paesi, e in particolare del nostro, ancora una volta risultano legate ad un sistema di regole sostanziali e processuali, all'efficacia dell'ordinamento giuridico e al corretto funzionamento della giurisdizione.
5) Il cattivo funzionamento della giurisdizione, insieme ad altri fattori ordinamentali e sociali, non solo depotenzia uno dei fattori di competitività del sistema economico, ma si fa essa stessa vis abctrativa e nutrimento dell'illegalità e del malaffare. La criminalità organizzata, la corruzione, l'evasione fiscale, l'illegalità diffusa, producono, secondo le stime di Banca d'Italia, un'economia sommersa ed illegale superiore ad un terzo del reddito nazionale. Se riuscissimo a far emergere, e qualcosa per fortuna sta accadendo, una quota rilevante di tale imponente massa finanziaria restituendola al circuito legale, non soltanto saremmo un Paese eticamente migliore, ma forse potremmo risolvere una parte importante dei problemi del bilancio pubblico e della insoddisfatta domanda di istruzione e protezione sociale, nonché far fronte alla povertà, ormai sempre più diffusa.
Dunque, anche qui il diritto e la giurisdizione costituiscono fattori decisivi per le dinamiche economiche e sociali.
Credo che a questo punto, alla luce di tali fatti e valutazioni che ho richiamato, cominci ad essere più chiara la tesi che vorrei provare a sostenere circa il rapporto storicamente difficile tra diritto ed economia declinato ai problemi dell'oggi.
La prima indicazione che vi propongo è che le dinamiche economiche globali, cui ho fatto riferimento, e le trasformazioni determinate dalla rivoluzione digitale si governano conferendo maggiore forza al diritto, alle regole, nella dimensione sovranazionale e nazionale, e alla capacità degli Stati di farle rispettare.
In una fase storica nella quale l'economia, e in particolare i mercati finanziari, sovrastano le politiche economiche degli Stati e persino, non di rado, i loro sistemi giuridici, l'unica risposta possibile e comunque quella più efficace è da ricercare nelle regole, nel diritto. Se così non sarà, gli attori economici e finanziari che agiscono sui mercati saranno inesorabilmente tentati di dettarle loro le regole, e di individuare, come sta già accadendo, gli strumenti per risolvere i conflitti.
Il rischio è che si strutturi una sorta di ordinamento separato e di giurisdizione “in house” dove necessariamente il dato della forza economica e della capacità di influenza sono destinati a prevalere.
Sintomatico di tale rischio è il contenuto di una parte del TTIP (Transantlantic Trade and Investment Parntership), un accordo finalizzato all’integrazione economica tra Unione Europea e Stati Uniti, la cui definizione è discussa da qualche anno ed è tuttora controversa. In una sezione dell’ipotesi di accordo, si ammette la possibilità che gli Stati possano essere chiamati in giudizio davanti a corti arbitrali da individui e società che si ritengono danneggiati da divieti imposti ai loro comportamenti da parte degli stati stessi. Come fatto rilevare dal professor Marcello De Cecco in un recente articolo, “si tratta di una innovazione giuridica che serve a limitare drasticamente la sovranità degli stati, favorendo ad esempio grandi società multinazionali, che non esiterebbero a chiamare in giudizio, davanti alle già dette corti arbitrali, gli stati invadendo la sovranità giuridica che essi hanno sui propri territori”.
Dunque, nella fase di massima espansione territoriale e dimensionale delle imprese e dei soggetti economici in generale, c’è bisogno più di prima del diritto.
Non so se è possibile parlare di una sorta di “rivincita” del diritto sull'economia.
Richiamo le considerazioni di partenza, in particolare di Smith e Marx, secondo i quali il diritto serve solo ad attuare gli obiettivi della scienza e delle politiche economiche.
Nell'economia globale, il diritto non può essere ridotto a strumento delle dinamiche economiche ma è destinato a condizionarle, orientarle e riplasmarle.
Altrettanto rilevanti sono, poi, la funzione della giurisdizione e il valore dell'indipendenza dei giudici; si tratta del predicato che la Costituzione associa alla figura del magistrato quale parte dell’ordine giudiziario, ai sensi dell’articolo 104 della Carta costuzionale. Il binomio “autonomia e indipendenza” risulta quindi decisivo al fine di consentire al diritto di stabilire una sua primazia sugli effetti economici distorti che possono generare diseguaglianza e ingiustizia sociale.
Diviene allora chiaro, alla luce di quanto si è andato esponendo, che assicurare prevedibilità, certezza ed effettività alle norme giuridiche e garantirne l’esecutività mediante un sistema giudiziario connotato da autonomia e indipendenza, rappresentano le condizioni senza le quali ogni ordinamento giuridico, e con esso i diritti della gran parte dei cittadini, soccombe agli effetti dei cicli economici negativi e alla forza delle dinamiche dell’economia globale.
Infine, una seconda prospettazione conclusiva.
La globalizzazione ha determinato crescenti diseguaglianze del reddito e della ricchezza, sia nelle economie avanzate che in quelle emergenti. Sempre Roubini afferma che “quali che siano le cause, l’aggravarsi della disuguaglianza ha generato malcontento e timori per la globalizzazione e il libero scambio”.
A proposito degli effetti della recente depressione economica globale, Amartya Sen afferma che “coloro che ne sono stati colpiti con maggiore violenza sono persone che si trovano al fondo della piramide nei rispettivi paesi e nel mondo in generale. Le famiglie che già versavano nella condizione peggiore per affrontare qualunque ulteriore avversità hanno spesso sofferto di una deprivazione ancora più bruciante in termini di perdita del lavoro, perdita della casa, perdita di assistenza medica e altre calamità che hanno afflitto la vita di centinaia di milioni di individui”.
Secondo i dati ISTAT in Italia al 2013 le persone in povertà relativa sono il 16,6% della popolazione (dieci milioni e quarantottomila persone), quelle in povertà assoluta il 9,9% (sei milioni e ventimila), numeri vertiginosamente cresciuti dall’esplosione della crisi in avanti.
Le condizioni di povertà e di esclusione spesso sono associate al crescente deterioramento ambientale e alle minacce alla sostenibilità.
Gli enormi problemi posti dalla globalizzazione e dalla grande crisi hanno determinato il sorgere di una corrente di pensiero che ha il suo punto più avanzato ed elaborato nella teoria della decrescita elaborata da Serge Latouche con una "critica radicale della nozione di sviluppo" ed una vera e propria "’decostruzione’ del pensiero economico".
Se vogliamo continuare a credere nello sviluppo, che non può che essere sostenibile, il problema dell’uguaglianza nella distribuzione dei redditi e della ricchezza, il contrasto alla povertà e l’enorme tema della sostenibilità devono assumere centralità nelle politiche degli Stati e alla dimensione europea e globale.
Contrastare le ingiustizie sociali non può più essere relegato a politiche di nicchia o affidato a strumenti residuali di welfare e tantomeno ad un approccio caritatevole.
E’ certo che non sarà il mercato a fornire le risposte che servono, giacché la causa prevalente della crescita delle diseguaglianze è da ricercare proprio nelle dinamiche mercantilistiche e liberiste.
Abbiamo dunque la possibilità e il dovere di cogliere le sfide che la crisi ci pone.
Secondo Ivan Illich, “Crisi (…) può indicare (…) quel momento meraviglioso in cui la gente all'improvviso si rende conto delle gabbie nelle quali si è rinchiusa e della possibilità di vivere in maniera diversa. Ed è questa la crisi, nel senso appunto di scelta, di fronte alla quale si trova oggi il mondo intero”.
La giustizia redistributiva e una maggiore uguaglianza tra i cittadini è una necessità inderogabile anche per tentare di uscire dalla crisi. Solo la politica e il diritto possono coltivare l'ambizione di realizzare tali obiettivi.
Per dirla con Amartya Sen : "Per ridurre le diseguaglianze abbiamo bisogno di un intervento più forte da parte delle istituzioni "non di mercato" atto a favorire democrazia, diritti umani, libertà di stampa, istruzione e assistenza sanitaria, e più in generale a incentivare un approccio solidale, una sorta di cooperazione globale, che vada al di là delle consuete relazioni d'affari tra paesi."
Molto si determinerà su scala globale ma ciascuno degli Stati deve percorrere la sua strada.
La nostra c'è: la indicò più di 35 anni fa, ancora una volta, Federico Caffè che disse: "oggi ci si trastulla nominalisticamente nella ricerca di un nuovo modello di sviluppo. E si continua ad ignorare che esso, nelle sue ispirazioni ideali, è racchiuso nella Costituzione”.
“I responsabili della politica economica ricordino più spesso (in verità imparino a ricordare) che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini".
Questo indica la nostra Costituzione all’art. 3 e questo è anche il mio convincimento oggi.
Grazie ancora, Magnifico Rettore, per l'onore che la 'mia' Università mi ha voluto oggi riservare.